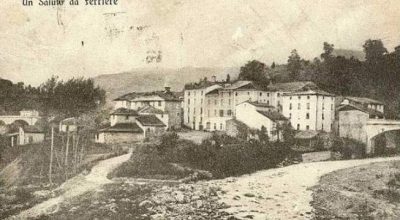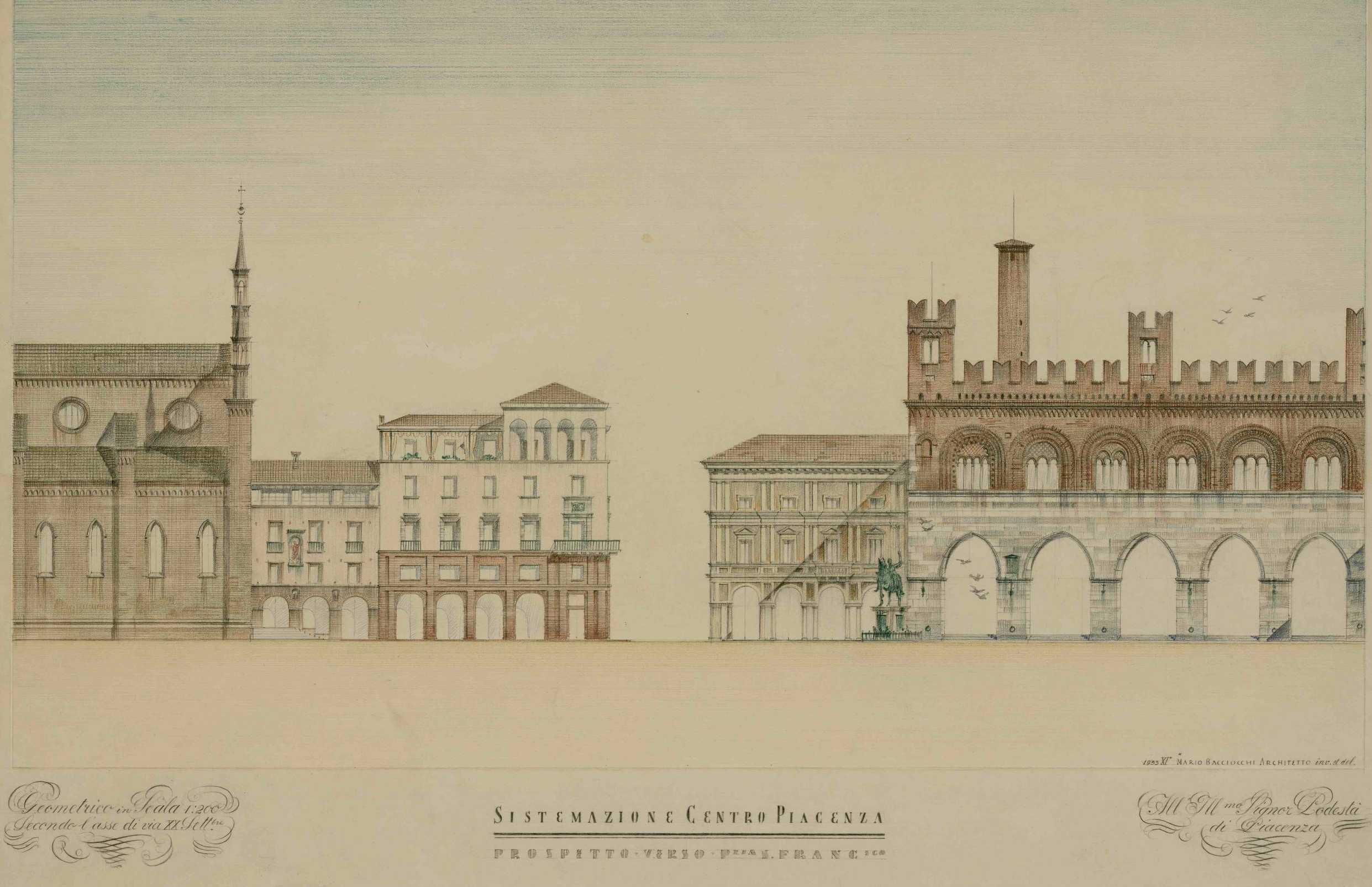FERRIERE IN VAL DI NURE
I Giovedì dell’Archivio – Giovedì 21 marzo 2024 alle ore 17,30, Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29 – Piacenza – Presentazione del libro di Gian Paolo Bulla in dialogo con Enzo Latronico con la partecipazione dell’editore Sandro Beretta (Le Piccole Pagine).

 ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA
ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA