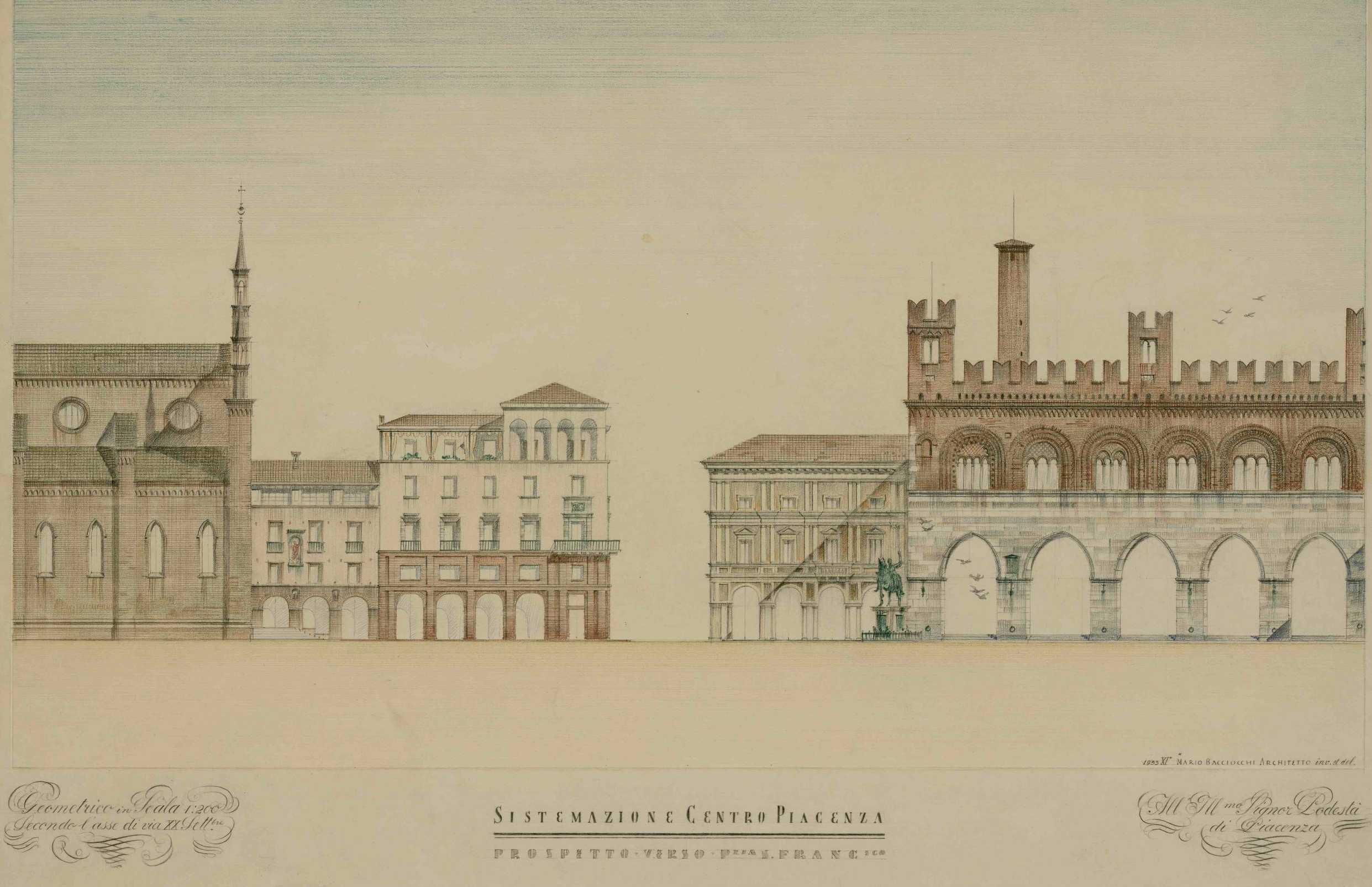I RIBELLI DEL GIOIA
Archivio di Stato di Piacenza, Palazzo Farnese – mercoledì 24 aprile alle ore 17 – Gli studenti della classe V classe A del liceo “Melchiorre Gioia”, coordinati dalla professoressa Marisa Cogliati, presentano la ricerca sugli studenti della loro scuola caduti durante la lotta di Liberazione.

 ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA
ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA